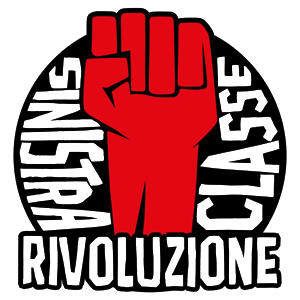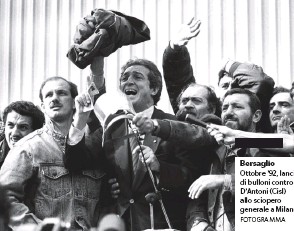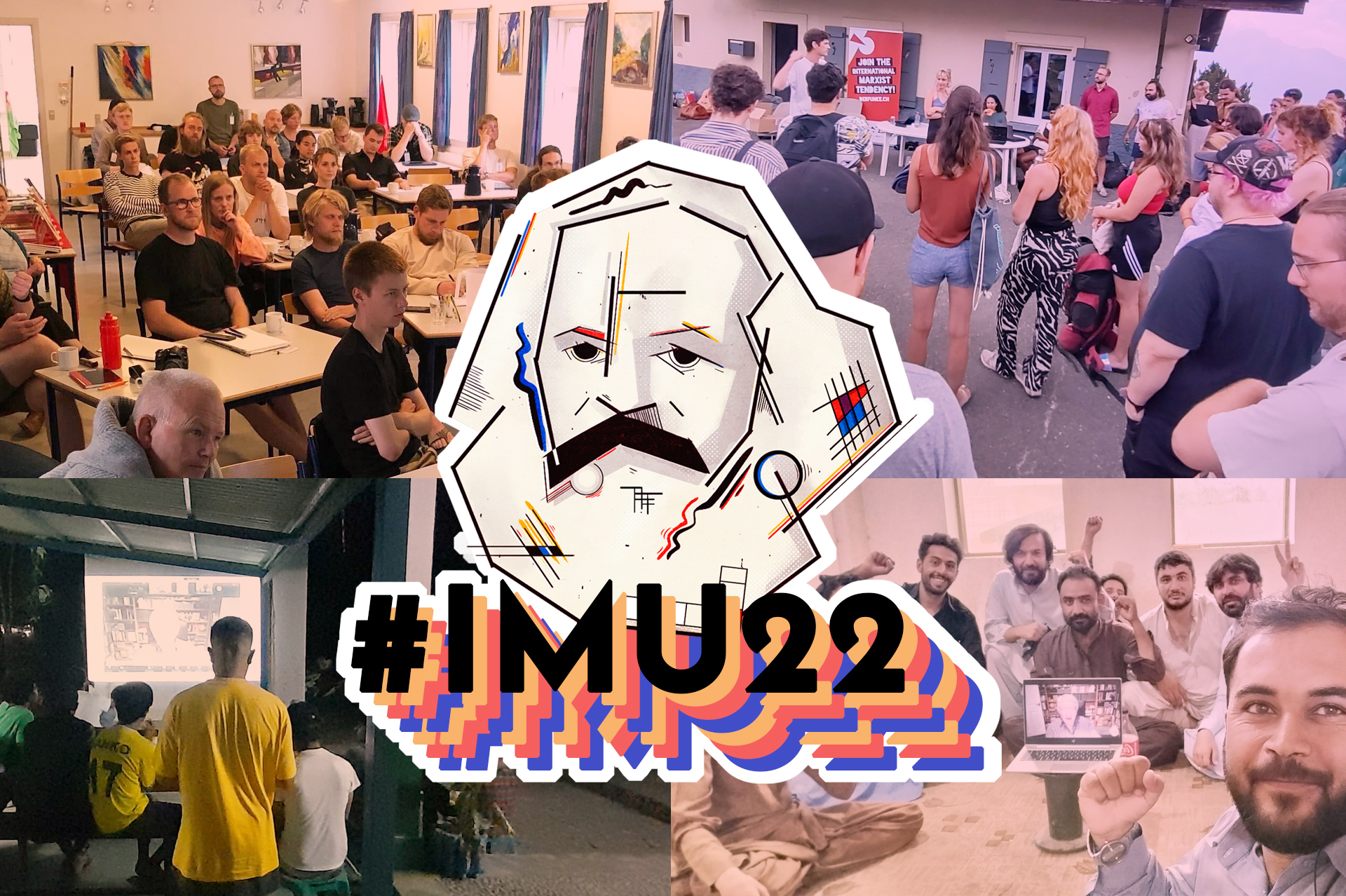
Università marxista internazionale 2022 – Un successo straordinario!
27 Luglio 2022
Agosto 1922 – L’offensiva squadrista e le barricate di Parma
1 Agosto 2022 Il 31 luglio 1992 i vertici di CGIL, CISL e UIL, il governo Amato e Confindustria firmano i primi famigerati accordi sulla moderazione salariale e aboliscono la Scala Mobile dei salari. L’anno seguente, il 23 luglio 1993, un altro accordo altrettanto peggiorativo fa da apripista agli attacchi dei decenni successivi. Se oggi i lavoratori italiani sono tra quelli coi salari più bassi, la precarietà più diffusa ed il sistema pensionistico peggiore dell’Europa occidentale, quello è stato il punto di partenza.
Il 31 luglio 1992 i vertici di CGIL, CISL e UIL, il governo Amato e Confindustria firmano i primi famigerati accordi sulla moderazione salariale e aboliscono la Scala Mobile dei salari. L’anno seguente, il 23 luglio 1993, un altro accordo altrettanto peggiorativo fa da apripista agli attacchi dei decenni successivi. Se oggi i lavoratori italiani sono tra quelli coi salari più bassi, la precarietà più diffusa ed il sistema pensionistico peggiore dell’Europa occidentale, quello è stato il punto di partenza.
Il 31 luglio 1992 è la conseguenza logica dei cedimenti dei vertici sindacali negli anni precedenti. Nel 1976, con la svolta dell’Eur, CGIL, CISL e UIL inaugurano la fase dei sacrifici. Segue la sconfitta alla Fiat del 1980, l’abolizione del punto unico di contingenza nel 1984 e la disdetta da parte di Confindustria della Scala Mobile nel 1991. Per la borghesia abolire la Scala Mobile ha anche un valore simbolico, ovvero chiudere col decennio delle lotte operaie innescato dall’Autunno Caldo del 1968-69.
L’accordo è firmato a fabbriche chiuse per ferie: è una manovra per cercare di evitare la contestazione dei lavoratori. La capitolazione della CGIL è siglata dalla firma del segretario generale Bruno Trentin. La CGIL è in crisi di autorità. L’esperienza degli autoconvocati in difesa della Scala Mobile nel 1984-85 è un ricordo vivo. In quell’occasione, di fronte all’attacco alla Scala Mobile, i sindacati confederali sono per la resa ma la risposta dei lavoratori è tumultuosa: in molte fabbriche partono scioperi indetti dai Consigli di Fabbrica (CdF) o dai loro coordinamenti. La direzione CGIL è costretta dalla pressione operaia a non firmare gli “Accordi di San Valentino”. La contrapposizione autoconvocati-vertice trova un’espressione anche nel congresso della CGIL del 1991, quando un settore guidato da Fausto Bertinotti (forte soprattutto nei metalmeccanici) presenta un documento alternativo “Essere sindacato” raccogliendo il 20% dei consensi.
“Si apre la stagione dei bulloni”
A settembre Amato torna all’attacco con una finanziaria da 93mila miliardi di lire e un pesante attacco alle pensioni. I sindacati convocano scioperi regionali di 4 ore. Lo scopo non è tanto quello di fermare Amato (ci vorrebbe ben altro), ma di far sfogare i lavoratori. Nelle piazze i lavoratori esprimono la loro rabbia contro Amato, ma anche contro l’accordo di luglio.
Trentin viene pesantemente contestato a Firenze, il 23 è il turno della UIL a Milano, il 24 della CISL a Napoli. È impossibile concludere i comizi: fischi e grida prevalgono, dalla folla piovono bulloni. La contestazione assume una tale portata che la stampa battezza quel periodo “la stagione dei bulloni”. I dirigenti sindacali parlano protetti dal servizio d’ordine munito di scudi di plexiglass. Stampa e mass-media, insieme ai vertici sindacali e ai dirigenti del Partito Democratico della Sinistra (il precursore dell’attuale PD), promuovono una campagna che definisce i contestatori un manipolo di provocatori. L’Unità del 23 settembre titola “L’autonomia assalta Trentin, ma 150mila lo applaudono”. La realtà è che i lavoratori non solo tollerano chi lancia i bulloni, ma fanno di tutto per impedire ai dirigenti di concludere i comizi a suon di fischi. L’autonomia e i sindacati di base non giocano nessun ruolo nell’organizzazione della protesta, ma vanno a rimorchio dei lavoratori e li invitano ad uscire dalla CGIL senza poter offrire reali alternative.
L’onda di contestazioni cresce di giorno in giorno, per tentare di arginarla e recuperare un minimo di credibilità viene convocato uno sciopero nazionale di 4 ore per il 13 ottobre. La storia si ripete, gli scioperi sono ancora più partecipati: Milano 150mila, 100mila a Bologna e Napoli, ancora contestazioni.
I consigli unitari

Dai giornali dell’epoca
I delegati sono sotto la pressione dei lavoratori. Quelli che qualche anno prima avevano dato inizio al movimento degli autoconvocati riprendono l’iniziativa. Parte Torino che raccoglie le adesioni di centinaia di delegati delle fabbriche più importanti. Il Consiglio di Fabbrica del Corriere della sera lancia un appello per un’assemblea il 20 ottobre. L’assemblea è un successo, il teatro straripa di delegati. Chiedono ai vertici di convocare al più presto lo sciopero generale, minacciando altrimenti di convocarlo loro entro metà novembre. Poi, siccome Amato accelera l’iter parlamentare della Finanziaria, decidono di aderire allo sciopero dei chimici per il rinnovo del contratto del 29 ottobre. Lo sciopero è un successo, gli autoconvocati aprono il corteo di Milano insieme ai chimici.
A quel punto i dirigenti sindacali capiscono che l’unico modo per fermare la protesta è sostenere il movimento a parole e svuotarlo nei fatti. Il movimento degli autoconvocati viene riorganizzato come movimento dei Consigli Unitari, il prezzo che la burocrazia impone ai delegati per garantire appoggio ed evitare rotture. Ciò significa che a decidere sono solo i CdF che rappresentano tutte e tre le sigle, costringendo la direzione dei consigli ad annacquare gli obiettivi in nome dell’unità.
Le ragioni della sconfitta
Il fattore decisivo che permette il processo di rientro degli autoconvocati è che i CdF non vengono rinnovati da anni e i delegati sono sempre meno rappresentativi dei lavoratori. Superata la prima fase di protesta, molti delegati si adattano all’apparato.
La FIOM vota un documento in cui accetta di fermare la mobilitazione in cambio della promessa che in futuro gli accordi dovranno essere votati dai lavoratori. L’area “Essere sindacato” si adegua.
I lavoratori avevano provato a reagire all’ennesimo tradimento. Per sei settimane avevano fatto tremare i polsi alla burocrazia, ma ancora una volta la mancanza di una direzione adeguata portò la lotta su un binario morto. “Essere sindacato”, che aveva conquistato consenso per essersi opposto agli accordi di luglio, si organizza soprattutto attorno alle posizioni conquistate negli organismi sindacali e non offre alcuna strategia per porsi come direzione alternativa nei luoghi di lavoro.
L’anno successivo il governo Ciampi, Confindustria ed i sindacati firmano i nuovi accordi, inaugurando la concertazione che ci opprime da trent’anni. Ricordare le origini della politica di moderazione salariale ci serve per capire che solo rompendo con questa linea portata avanti dai vertici sindacali si potrà tornare a lottare per condizioni più dignitose. Nostro compito è aiutare i giovani e i lavoratori a riscoprire le migliori tradizioni di lotta e le parole d’ordine più avanzate, imparando dalla storia e sapendo applicarle al contesto attuale.